Sono arrivata a Biškek in una mattina di luglio, molto presto. Il sole era ancora obliquo, rarefatto dall’afa dell’estate nella capitale kirghiza.
Non è l’impatto che abbiamo con le città vicine al nostro immaginario, ma questo lo sapevo. E del resto è quello che cerco.
I 30 minuti di van dall’aeroporto al primo luogo in cui potrò riposare dopo il lungo volo mi racconta già qualcosa:
Vedrò spesso e molto l’alternarsi tra un passo lento, nomade, tradizionale e una tendenza, quasi tensione, verso la modernità e tutti i suoi compromessi.

In questi consigli su cosa vedere a Biškek, capitale kirghiza, cercherò di liberarmi il più possibile del peso del mio l’immaginario italiano ed Europeo, per ascoltare, attraverso la città, le storie di un pezzo di mondo del quale noi non sappiamo praticamente niente.
Se sei disposta a farti lo stesso favore, benvenuta a Biškek, capitale del Kirghizistan.

Io sono Sabrina,
blogger.
Racconto le destinazioni in modo… politico.
Se questo approccio ti piace, ti somiglia, ti incuriosisce,
teniamoci in contatto.
Piazza Ala-Too: cuore simbolico di Bishkek
Trovo incredibilmente significativo, per raccontare la città e forse tutto il paese, che la piazza centrale, cuore simbolico di Biškek, sia delimitata dalle vie Kiev, Puškin, Razzakov e Panfilov.

In ogni città post-sovietica c’è una piazza che più delle altre conserva le impronte del potere, del cambiamento, delle rivolte. A Bishkek, quella piazza è Ala‑Too.
Un tempo si chiamava Piazza Lenin.
Oggi, al suo centro, svetta la statua di Manas, l’eroe epico nazionale, simbolo di forza, coraggio e, soprattutto, identità.
È stato scelto per sostituire la statua del vecchio leader sovietico nel 2004, come a voler riscrivere la narrazione del potere da conquistatore a leggendario padre fondatore.
La statua di Lenin, però, non è stata né abbattuta né distrutta, men che mai cancellata, ma ci torniamo tra un attimo.
Vicino a Manas, uno stendardo altissimo regge la bandiera del Kirghizistan, ricca di simboli che raccontano il paese:
le sue leggendarie 40 tribù (i 40 raggi) e il centro che richiama le aperture superiori delle yurte.
La bandiera è stata disegnata nel 1992, subito dopo l’indipendenza dalla Russia.
La Yurta la ritroviamo anche stilizzata in bronzo nella statua della vittoria, con la fiamma perenne dedicata ai caduti per la libertà e l’indipendenza.
Non è forse una piazza “bella” nella nostra comune concezione, ma è ricca di simboli, è “tesa”;
urla per richiamare le tradizioni, il passato e un’identità a lungo negata.
E’ il luogo della pacificazione nazionale, eppure è sempre qui che, nel marzo del 2005, migliaia di persone si sono radunate per rovesciare il presidente Akayev durante la cosiddetta Rivoluzione dei Tulipani, nata a seguito di presunti brogli elettorali, corruzione e atti di violenza del presidente e della sua famiglia.
Sempre qui sono passate le rivolte anti corruzione e deriva autoritaria del 2010, hanno portato ad una nuova costituzione, purtroppo dopo centinaia di morti.
A loro, è stata dedicata una statua, un altro dei simboli neoclassici della piazza.

Il museo statale di storia e la statua di Lenin

Davanti alla grande piazza Ala-Too, il Museo di Storia Statale del Kirghizistan si staglia come un blocco imponente di marmo e silenzio.
Da fuori sembra un sacrario dell’ideologia sovietica: linee squadrate, severità monumentale, vetrate senza fronzoli.
Da dentro, è un salto nella narrazione ufficiale e nel modo in cui un Paese rielabora e celebra il proprio passato mentre prova a costruirsi un futuro.
Tutta la storia del paese è raccontata qui, dalla più antica e i suoi miti, i suoi eroi nazionali (dei quali ti parlerò presto perché meritano un discorso approfondito), fino alle relazioni internazionali del presente;
L’allestimento passa attraverso gli anni zaristi, nell’URSS, ma anche nei costumi e nell’abbigliamento nomade (fin troppo bello).
Nel contrasto tra le teche statiche e la vitalità della piazza fuori che si coglie la frattura e la continuità della storia kirghiza.
E poi c’è lui, Vladimir Il’ič Lenin, scolpito con mano ferma e piazzato nel 1984 in posizione dominante sulla piazza retrostante il museo e Ala-Too.

Se quando è stata creata, era simbolico il gesto retorico, ora è simbolica anche la sua posizione.
Come se guardasse con diffidenza verso la il palazzo del Municipio, non guarda più il popolo, ma il potere.
Alla luce di tutto questo, alla luce della volontà di riaffermare in modo assertivo un’identità nazionale troppo a lungo negata dalla Russia, alla luce delle persecuzioni della cultura nomade fatta dagli imperi zarista e sovietico…
Perchè c’è una statua di Lenin, in una posizione così centrale?
E del resto, come mai la lingua russa è ancora una lingua ufficiale (e fino a pochi anni fa era addirittura prima lingua nelle scuole)?
I rapporti tra Kirghizistan e Russia, in realtà, non sono mai stati realmente ostili o distaccati, neanche dopo l’indipendenza.
Dal momento che buona parte del PIL dipende ancora dalle rimesse degli emigrati kirghsi in Russia,
dal momento che non appena cadono i fragili governi di una democrazia in costruzione, i leader si rifugiano in Russia o in Bielorussia e alla luce dei commerci ufficiali (e, ultimamente, ufficiosi) tra Russia e Kirghizistan, le relazioni è bene che restino distese e che i cambiamenti storici siano raccontati e ricordati come soffici passaggi di tempo.
La Casa Bianca, di una democrazia giovane

La Casa Bianca di Bishkek si affianca con imponenza su piazza Ala-Too.
Una facciata severa in marmo bianco, uscita da un manuale di architettura sovietica.
Sede del governo kirghiso, è al tempo stesso simbolo istituzionale e testimone silenzioso delle rivoluzioni che hanno attraversato il Paese.
Il suo aspetto granitico, quasi impenetrabile, contrasta con la vivacità della piazza che la fronteggia, dove si sono svolte proteste, rivolte e celebrazioni. Non è visitabile all’interno, ma resta uno dei luoghi più significativi per capire quanto il potere politico, in Kirghizistan, non possa mai essere separato dal paesaggio urbano.
Parco Panfilov

Se Ala-Too racconta il potere, il Parco Panfilov racconta la vita quotidiana.
Sotto la chioma fitta dei tigli e degli alberi di noce, questo grande parco cittadino accoglie le pause lente della capitale:
bambini sulle giostre un po’ retrò, studenti che chiacchierano all’ombra, uomini che giocano a scacchi come se fosse un rito laico.
Passeggiando, si incontrano statue che parlano di identità e memoria.
Tra tutte, quella di Kurmanjan Datka, la “Regina del Sud”, simbolo di resistenza e intelligenza politica in una terra storicamente patriarcale.
È grazie anche alla sua figura che oggi le nuove generazioni kirghize possono ricostruire un senso di sé radicato e fiero.
Il mercato di Osh: retaggio delle vie della seta

Osh è il nome di una città a Sud del Kirghizistan, una regione che si stringe tra Uzbekistan e Cina; è stata una città fondamentale per la Via della Seta.
Qui a Nord, a Biškek, le merci principali di questi scambi che rendevano l’Asia Centrale il centro dell’Economia mondiale, arrivavano proprio da Osh ed è per questo che il principale Bazar storico ancora esistente nella capitale ha questo nome.
La bellezza dei banchi di spezie e la loro incredibile varietà si unisce alla vitalità colorata dei suoi commercianti.
Tra donne che trattano, donne che recidono fiori, ragazze che impacchettano frutta secca uomini che smerciano tabacco, anziane che controllano le notifiche nei loro cellulari con cover a portafoglio, quello che si muove nella capitale del Kirghizistan passa, quotidianamente, da qui.

Il kumis, parte dell'economia nomade

Nelle strade della città, ma anche negli sterrati delle vie secondarie, e di certo agli ingressi di ogni mercato, compreso quello di Osh, troverai kirghisi dietro a banconi rudimentali, con ombrelli che fanno ombra su due taniche, una blu e una rossa.
Queste persone vendono Kumis, [qɯmɯ́z] bevanda centro asiatica, parte fondamentale dell’economia nomade del Kirghizistan.
Si tratta di latte di giumenta, fermentato, leggermente alcolico e incredibilmente dissetante.
La vecchia Moschea Centrale "brutalista"

Nascosta tra le pieghe meno battute del centro cittadino, in una traversa di Via Gogol, la vecchia Moschea Centrale di Bishkek è uno dei luoghi di culto più antichi della capitale, costruita nel 1886 e restaurata nel tardo Novecento.
Per anni è stata semplicemente “la moschea centrale”, fino a quando, di recente, il titolo è passato alla nuova e scenografica moschea di Makhachkala.
È un complesso discreto ma ampio, in stile di richiamo brutalista, che custodisce tre sale per la preghiera collettiva.
La sala grande accoglie oltre 600 fedeli, la seconda circa un migliaio. Ma è il venerdì, giorno sacro, che i numeri si amplificano: tra spazi interni e cortili, oltre 5.000 persone si raccolgono in questo luogo.
La nuova Moschea Blu di Bishkek


In molti la chiamano “la moschea blu” di Bishkek, per la sua somiglianza architettonica con quella di Istanbul.
Ma il suo nome ufficiale è Moschea Imam Serahsi, e il suo impatto visivo è tutt’altro che timido.
Finanziata e donata dalla Turchia, è stata inaugurata nel 2018 e rappresenta molto più di un luogo di culto.
È un gesto simbolico di vicinanza religiosa, certo, ma anche una dichiarazione geopolitica: la Turchia investe nella propria influenza culturale e spirituale nell’Asia centrale, rinsaldando legami con i popoli turcofoni come quello kirghizo.
Tra le altre cose, la Turchia di Erdogan crea università private in Kirghizistan erogando molte borse di studio, a patto che gli iscritti parlino il turco, implementando lo studio della lingua turca in Asia Centrale.
La moschea può ospitare fino a 20.000 fedeli, e domina il paesaggio con le sue cupole azzurre, i minareti svettanti e una cura estetica che richiama direttamente i fasti ottomani.
Teatro Nazionale dell’Opera e del Balletto: tra classicismo sovietico e ambizioni moderne

Tra i viali ampi e i blocchi architettonici ereditati dall’URSS, il Teatro Nazionale dell’Opera e del Balletto di Bishkek appare come un monumento al classicismo sovietico, tutto colonne, simmetrie e marmi chiari.
Ma dietro quella facciata severa, pulsa una scena artistica viva e profondamente kirghiza.
Costruito nel 1955, è stato per decenni uno dei cuori pulsanti della cultura nella Repubblica Socialista Sovietica del Kirghizistan.
Oggi ospita una programmazione che alterna repertorio russo, grandi classici europei e opere ispirate alla tradizione nomade e ai poemi epici kirghizi.
Tra l’eredità ancora visibile, i parchi pieni di famiglie e scacchiere, le moschee che raccontano storie di fede e politica, i mercati che odorano di spezie e fermentazioni antiche, Bishkek non è una città che si concede in superficie.
Non è la cartolina patinata dell’Asia centrale, qui si cammina tra simboli e contraddizioni, in bilico tra memoria e trasformazione.
Come il corpo nomade dei suoi atleti a cavallo, anche Bishkek cerca il suo equilibrio. E a chi la guarda con occhi aperti, offre molto più di quanto prometta.

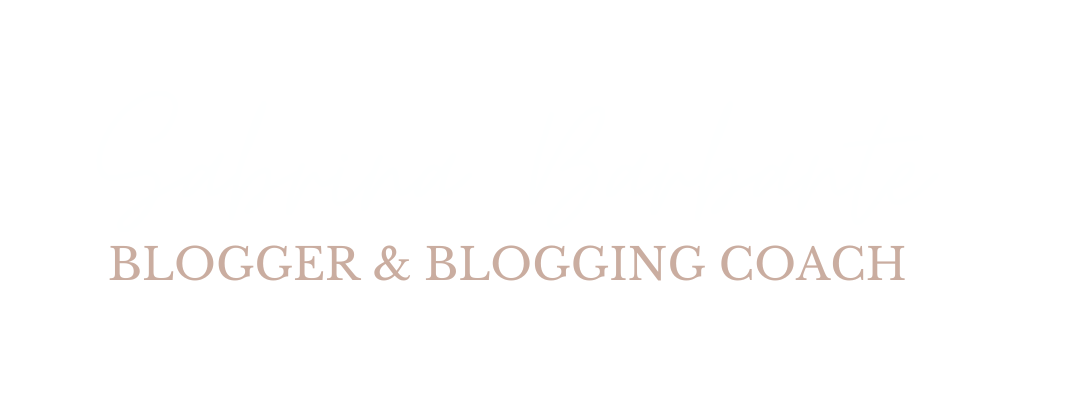



Lascia un commento